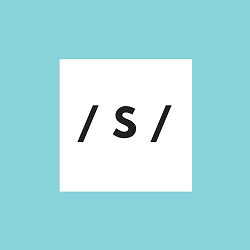Maria Grazia Insinga, un’intervista tra musica e poesia
Maria Grazia Insinga (Milazzo, 20 aprile 1970), dopo la laurea in Lettere moderne, il Conservatorio e l’Accademia musicale si dedica all’attività concertistica. Nell’ambito degli studi musicologici censisce, trascrive e analizza i manoscritti musicali inediti del poeta Lucio Piccolo. È docente di ruolo presso l’Istituto “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando dove insegna Pianoforte. Per fare poesia con gli studenti delle scuole, idea due premi: nel 2014 La Balena di ghiaccio, il premio di poesia per i giovani in memoria del poeta Basilio Reale, sostenuto dall’Assessorato ai Beni Culturali di Capo d’Orlando e dal LOC Laboratorio Orlando Contemporaneo; nel 2019 il Premio Lighea, patrocinato dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana e organizzato dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. Dal 2016 al 2019 è membro del consiglio editoriale di Opera prima, iniziativa editoriale diretta da Flavio Ermini. Dal 2020 fa parte della giuria del Premio Lorenzo Montano e del Comitato di lettura di Anterem Edizioni.
Tra le sue pubblicazioni in versi: Persica, con le illustrazioni di Emanuela Fiorelli, raccolta vincitrice del concorso Opera prima (Anterem, 2015); Ophrys, con le illustrazioni di Eunice Kim, raccolta finalista al XXX Premio Montano (Anterem, 2017); Etcetera, con le illustrazioni di Alessandra Varbella, in forma di leporello in versi (Fiorina, 2017); La fanciulla tartaruga, con le illustrazioni di Stefano Mura, in forma di carnet de voyage (Fiorina, 2018); Tirrenide, raccolta in versi vincitrice della XXXIII edizione del Premio Lorenzo Montano (Anterem, 2020).
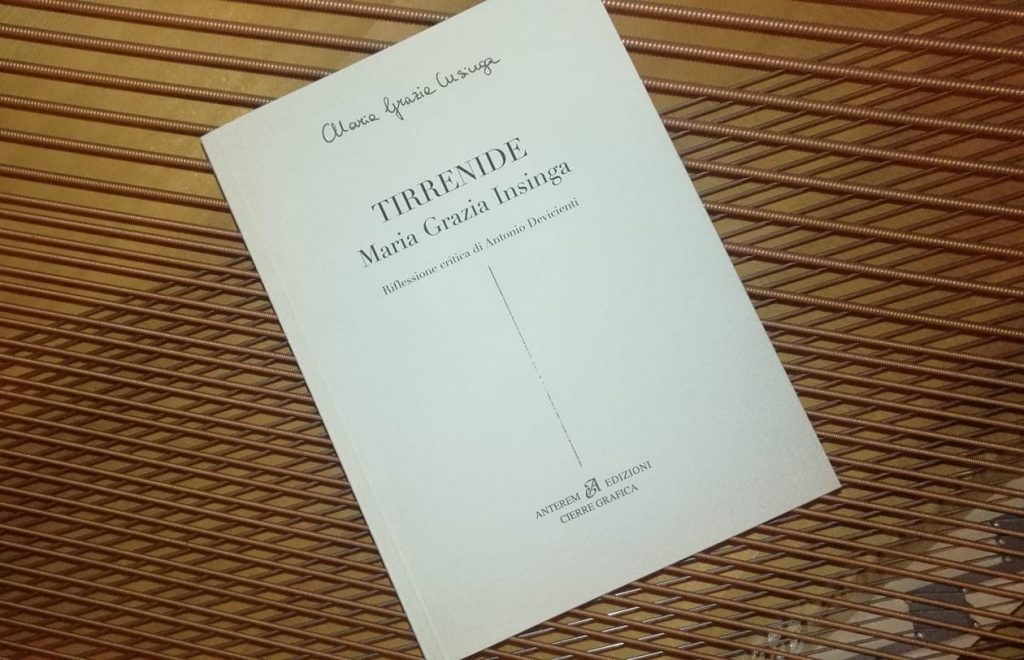
*
dare forma e poi rimettere le mani in pasta
e recreare un’altra forma prossima all’infanzia
della precedente e precederla in un cerchio
un ciclo due anzi un triciclo o l’uroboro
*
la forma nello spazio è pur sempre distanza e pure
luogo e lì si toccano e c’è nell’intero di chi è solo
una misura di prosa che qui non c’è non c’è racconto
non dirsi ma essere che va verso un altro intero
per contraddirsi dirsi contro e dunque forma dimmi
Spazio e tempo sembrano divorarsi come fa l’uroboro che si mangia la coda, «tutto può accadere e il nulla accadeva». Che luogo è Tirrenide?
Tirrenide è poema del sogno e trae epico spunto, ma è un’epica antieroica, dalle origini oscure di un continente sommerso che riecheggia l’Atlantide platonica; trae spunto anche dalle origini oscure dell’approdo orlandino – Capo d’Orlando, dove vivo, a un soffio dalle Eolie – per arrivare alle origini oscure dell’uomo e a quelle del suo poetare. In un’opera di Jean Giraudoux intitolata Ondine, la sirena chiede al poeta: Qual è stato il vostro primo più bel verso? e questi risponde: Non lo so più. L’ho scritto in sogno. Storicamente Tirrenide è un’entità economico-politica che si colloca nel Medioevo Ellenico tra le due fasi di egemonia greca: micenea ed ellenica. Quella micenea, imperniata sul regno di Eolo, si lega alla fondazione stessa di Capo d’Orlando, ad Agatirno (dal nome di uno dei figli del re). Agatirno, in un secondo tempo, sarà conosciuta anche come Agatirso, nome che indica il “portatore di tirso”. E il tirso è uno strumento dionisiaco, liturgico e musicale.
Traducendo queste origini oscure in musica, dunque, si potrebbe dire che la mia Tirrenide è un continente sommerso che nasconde qualcosa: i suoni armonici. Quando percepiamo un suono, noi crediamo sia un unico suono; insieme al suono fondamentale, in realtà, ce ne sono altri concomitanti e che possiamo definire l’anima del suono stesso e senza i quali esso sarebbe percepito come metallico, freddo. I suoni armonici rappresentano, in un certo senso, quello che definisco l’assoluto non verbale: tutto quello che diciamo nelle parole che abbiamo scelto di non dire o nel senso nascosto in quelle che abbiamo scelto di dire. Questo indicibile “sovrappiù di armonici” indica che i versi non possono essere segmentati in base alla metrica tradizionale, e che invece devono essere letti ad alta voce, ingoiati interi come in un atto di cannibalismo. Ecco perché la punteggiatura è totalmente assente, perché “l’essere non è segmentato”, è intero; ecco perché la lettura ad alta voce recupera quel suono venuto meno nella dimensione plumbea della pagina scritta.

È in tale procedere della parola – intesa come paradigma del margine – che non si “distingue la fine dall’inizio la destra da sinistra”, origine e fine e terra e mare. Su quel margine ondoso popolato da creature ibride, le tuffatrici capaci di lanciarsi da dirupi fonetici e figlie di un sortilegio – quello della voce direbbe la Sirena di Tomasi di Lampedusa – appare l’uroboro, il serpente simbolo primordiale del ciclo vitale che incide “la lallazione del tempo” sulla iancura (biancore) dove si intravedono appena i contorni dell’arcipelago eoliano dalla costa tirrenica. Il rapporto tra biancore e mare in bonaccia è evocato già in Omero (galéne). Galene è anche, fra i miti esiodei della Teogonia, la divinità del mare calmo, una delle Nereidi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀non voltarti verso i seni
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀la persuasione è fuori stradaci siamo concesse un secolo appena di debolezza
e ora alle quattro meno un quarto ancora iancura
non distingue la fine dall’inizio la destra da sinistra
e corre guida lo strumento con una mano l’altra scuote
i sonagli dell’aria così mentre scrive in corsa aspide
senza mani continua a suonare il cruscotto con le dita
la lallazione del tempo promette una selezione bianco
celeste di mutismo su bianco celeste delle madreisole
Quando, sul filo dell’arcipelago eoliano si verifica questa illusoria unità visiva, quasi un ritorno all’informe tempo primo delle origini, è come se il paesaggio ingoiasse i contorni del paesaggio svelandosi nell’intero sinestetico. Ci sono termini dialettali che non possono essere né sostituiti né tradotti e che entrano con naturalezza nella lingua poetica. Il poema del sonno è, quindi, punto di incontro di lingue per le quali la musica è ponte modulante, tirso bacchico, emersione di un’identità, di un linguaggio “altro” dal continente Tirrenide, dal suo fondale sonoro.
La tua raccolta si apre con un’«ambiguità essenziale», come la chiamerebbe Blanchot. «Nessuna dedica all’altra». Quell’altra che pure attraversa ogni pagina e che non puoi fare a meno di cercare: «una è nera l’altra bianca chi l’una / chi l’altra uguali dunque diverse». Ma chi è l’altra, e chi sono gli altri?
È vero, colta in flagranza. In Tirrenide la parola “altra” è presente con ben 34 occorrenze (39 se si considera la versione integrale, visto che quella pubblicata da Anterem nel 2020 manca di una sezione). Anzi, a dirla tutta, l’altra è presente sin da Persica (2015) e attraversa Ophrys e Etcetera (2017). E a dirla proprio tutta tutta, l’altra è presente persino, soprattutto, nelle dediche che “aprono” ciascun libro così come una chiave aprirebbe la serratura (tranne Oprhys che reca la dedica “A Nike e a Nike” che indica, in fondo, un’altra Nike). In questo protendersi dei versi verso l’altra è il luogo della recreazione, della forma venuta fuori dal tentativo di colmare una distanza con la parola. Qui, re-creare ha il duplice senso di creare di nuovo e il senso di “arricriare”, ristorare, vivificare tipico della lingua siciliana che conserva ancora in sé il latino da cui origina. L’altra è colei che cavalca su posidonie in una regione del cervello piena d’acqua, lei che succhia i fiori all’altezza degli alberi pizzuti dove schiatto, lei nella testa scoronata, lei di me la maggior parte, lei pesce angelo che mi vola di canto al sonno. Nella sua riflessione critica, Antonio Devicienti, lungimirante, scrive «[…] e suggerisco, in conclusione, di riflettere sul provocatorio incipit (“nessuna dedica all’altra”) che, riallacciandosi alle “dediche” dei libri precedenti, dice di quanto Tirrenide sia opera che vada letta anche immaginandosi testi-ombra o assenti o paralleli, proprio in una concezione “quantistica” della scrittura». È vero.
La dedica è un incipit primordiale, fuoco e squaglio. C’è una storia che lega i miei libri che sono al tempo stesso autonomi; c’è un dialogo con l’altra che lega e slega il mio racconto in versi. Un dialogo che si conclude, almeno apparentemente, proprio in Tirrenide con la dedica che recita paradossalmente “nessuna dedica all’altra”. L’altra è una voce che “arriva a qualcuno nel buio. Immagina. A qualcuno riverso nel buio”. Questo sì che è un incipit primordiale: quello di Beckett in Company. Tirrenide è la recreazione, la “resurrezione vocale” dell’altra – parafrasando Ceronetti – ed è suono vitale e armonico sotterraneo: una musica senza musica, musica in assenza di sé, in attesa di che? dell’altra. Il tutto amplificato da un’aspra ironia. L’altra è l’attesa: il terrore di un’assoluta scissione tra parola e soggetto, parola e cosa; la necessità di riunire il reale in unità, nell’intero dell’ultima sezione del libro; l’urgenza di unire chi scrive a chi ascolta, al lettore, il liutaio. L’altra è, in definitiva, il terrore di non riconoscere la propria voce-identità, potenza linguistica che forgia quell’identità, e unico lume che arriva dall’esterno nell’intrico del sé. Vado giù di voce per muovere trilioni di acqua, per smuovere l’altra a coincidere nell’una, in me – “sotto una lingua a rullarne un’altra/scava intere città cammina sull’acqua” – ma niente: il giorno precede la veglia da più notti che giorni per un errore di calcolo; e, dopo l’ultimo giorno, l’ultimo giorno dopo l’ultima notte, il tentativo di autoritratto dell’altra in me non va a buon fine. I conti tornano sopraffatti fruttuosamente e io, convinta, continuo ad abbassare la realtà, abbassare la voce, a ridurla ai minimi termini per prostrarla alla mancata unità tra me e l’altra: l’altra rimane l’altra. L’altra resta una dislocazione a sinistra di chissà quale altrove, chissà quale niente; e torna tutto, gira tutto in altro e solo in sogno. L’intero androginico resta il sogno sirenico e della poesia.
Ma a chi importa la chiave della mia poesia? A chi importa la storia di chi scrive? Lo scandalo, giustamente, soverchia sempre troppo la voce. È per questo che lo scandalo non dovrebbe stare al centro dei versi; al centro c’è sempre la storia di chi legge, non di chi scrive. A meno che la storia in versi non si faccia mattone-parola e la lettura decostruzione del sé di chi legge la storia, del liutaio. La storia storta ferisce e riferisce ciò che non si può riferire.
violoncello anzi cello
questa la traduci in un numero di sillabe ma resta
un altro il numero un’altra la musica non importa
delle contaminazioni infili tutto nel bianco corno
di chi di cosa e senza soprattutto i tagli a f a sorsi
a tonnellate f senza f perdono senza fissa f tana
sette volte sette senza f senso va bene così finita
f adesso un po’ prima della parola f fine vedi?
La mia scrittura, per le sue peculiarità, risulta di difficile traduzione. In questo testo rifletto sulla parola “violoncello” che in altre lingue è codificata in “cello”. Naturalmente, la scelta di una o dell’altra cambia radicalmente in termini di musicalità poiché si passa da un quadrisillabo a un bisillabo. La f di cui parlo è la f che si trova, appunto, negli strumenti ad arco. Si tratta di tagli a effe sulla tavola armonica che si presentano, in fondo, come ferite ma che sono anche passaggi, fessure collocate ai lati del ponticello con lo scopo di permettere al suono di fuoriuscire. Inoltre, sono utili al liutaio per l’accesso all’interno della cassa armonica. Ecco, per entrare all’interno di un testo poetico, credo che l’unico accesso sia una ferita, una effe, insomma. E il lettore non è altro che un liutaio che tenta di comprendere il meccanismo del violoncello. Nell’opera di Man Ray, Le violon d’Ingres, l’artista aggiunge sulla foto che ritrae di schiena la modella le due effe con l’inchiostro nero: e il corpo diventa un violino di carne e ossa.
Dopo la laurea in Lettere Moderne, il Conservatorio. Che rapporto c’è fra la tua poetica e la musica?
Che peso avrebbe sulla mia poetica se rispondessi: “non c’è alcuna somiglianza tra linguaggio poetico e linguaggio musicale”; oppure se rispondessi: “non c’è alcuna differenza tra linguaggio poetico e linguaggio musicale”? Nessuno, spero. Alla poesia non servono generi e sfere linguistiche, non serve distanza o contiguità tra discipline, non serve la prima, la seconda né la terza persona, non serve neppure la musica. Alla poesia non serve nulla. Soprattutto, non le serve opporre una cosa a un’altra. E questo stato di cose equivale all’intero, alla libertà: le uniche cose di cui la poesia non può fare a meno.
Essere musicista significa per me non vedere differenze tra emissioni armoniche e fonetiche. Voglio essere intera, libera e non scorgo dimensioni binarie nella realtà poetica e neppure in quella umana. Una cosa non esiste in opposizione a un’altra: esiste e basta.
L’altra nella vita è l’altra – vi basti – l’altra in poesia è Amelia Rosselli. La Rosselli raggiunge l’intero nella Libellula dove la sequenza anapestica o giambica è disattesa; lontana da ogni schema metrico codificato, con i suoi spazi che paiono fondarsi sulla misura del fiato. Insomma, leggo in cinque ictus, o meglio cinque fiati questo panegirico della libertà, e tutto è unità, libertà; come quando di fronte a qualcosa di lungamente incompreso è l’intuito a saltare i passaggi dell’equazione, a fare coincidere finalmente chi scrive e chi legge, l’una e l’altra:
rovEnte mUro del solitArio! strappAnti intEnti
cannibalEschi, Oh la sErie delle divisiOni fuOri
del tEmpo. DIssipa tU se tu vuOi questa dEbole
vIta che non si lAgna. ChE ci rEsta. DIssipa
L’alterità della Rosselli è un tu, la mia alterità è l’altra. Ci sono voci mitiche, voci poetiche e voci umane nella scrittura. Le registriamo mille e mille volte fino a quando – novelli Krapp – ci riconosciamo nella voce registrata, fino a quando l’altra voce coincide con la nostra nell’intero. La lettura esofasica – oralità, poesia per gli occhi e insieme per le orecchie – corrisponde a un parto sirenico, sonico, in cui la ricezione consente di riconoscere il suono materno, riconciliarsi con esso, tornare a casa. Una archeologia della voce dove i fiati primordiali, come le briciole di Pollicino, riportano all’origine, a casa.
Ho sempre creduto che sia il ritorno periodico degli accenti – o delle briciole – nel flusso parlante a cullare, a generare l’induzione motoria, la musica di la ‘ncunia dove l’incudine è lingua che batte e sbatte sui caratteri plumbei di un foglio bianco (di ddocu veni a musica!). I poeti sono sempre i Velázquez nella fucina di Vulcano, sono i mitici Dattili, les marteaux sans maître, i creatori della musica nata non dal canto degli uccelli ma dal rumore delle lingue, dei martelli che gli operai “battono armoniosamente in cadenza”, scrive D’Alembert. Immagini, suoni e parole servono a dare ordine e ritmo nell’immaginario della coscienza; rimandano al tempo, al suo fluire; allo spazio, la sua presenza, la sua assenza; all’unità, insomma, che l’io tenta di raggiungere tramite l’opera d’arte, l’androginia della creazione nel suo ineluttabile destino di disfacimento. L’io poetico sta in bilico tra Mosè e Aronne, tra la purezza dell’idea inesprimibile e la parola. Quello della poesia è un linguaggio vero e proprio, metalinguaggio, koinè estesa quanto quella musicale; forma significante le cui strutture presentano somiglianza con la nostra vita spirituale che può così essere colta anche intuitivamente. Non è dunque un linguaggio come il parlato ma può essere considerato lingua metaforica, ibrida con un potere superiore a quella parlata. Il linguaggio non è sufficiente a cogliere i nostri stati emotivi, non è sufficiente a cogliere i movimenti del corpo e della psiche, a mettere a fuoco l’indicibile, la bellezza nella sua caducità. Il dolore provocato da tale caducità produce l’attesa di una nuova realizzazione della bellezza. La musica e la poesia soddisfano naturalmente questa erotica attesa grazie al rinnovarsi kierkegaardiano dell’ascolto-lettura.
Poesia, pertanto, come iniziazione al suono per il tramite corporeo della parola. Il mio bilinguismo poesia-musica si esplica nel gesto sonoro che abbraccia la loro unità melogenetica. Reiterando la lettura ad alta voce le parole perdono il senso di sé per diventare suono, smettono di denotare e iniziano a connotare restituendo nuovi significati come se rinascessero dall’ipnosi esofasica, dal piombo dei caratteri tipografici. Il bergsoniano tempo interiore, la durée réelle, anela così a diventare spazio, reificazione di sé: tempo e spazio “simboli non consumati”, scrive Susanne Langer, di una partitura poetica. Per rompere l’incantesimo che ha trasformato lo spirito in carta e scacciare gli spiriti malefici che si irrigidiscono nel senso rinunciando al suono o che si abbandonano al suono rinunciando al senso, invocherei volentieri lo spirito di Berlioz e il suo coro di demoni de La damnation de Faust che intona un testo privo di qualsiasi significato e ricco di armonici: “Has! Irimiru Karabrao! Has! / Has! Has! Méphisto!” Un pandemonio, la poesia. Intelligibile e intraducibile allo stesso tempo esattamente come la musica, la poesia proprio per questo rivendica spazio all’oralità, per rinominare il mondo, farlo riapparire dopo la sua scomparsa nel silenzio plumbeo tanto distante dalla strada, ricrearlo nella fucina di una nuova fabbrica illuminata.
Leggendo le tue poesie, l’impressione è quella di essere immersi in un’officina dove il testo è nel suo farsi, una «dispersione spogliata». Il paralinguaggio si sostituisce al linguaggio. Il significato lascia il posto alla significazione, con la sua ricchezza di senso. Ogni termine non è indifferente, ma è passibile di essere interpretato nel suo contrario o di non trovare interpretazione, davanti alla complessità di questo «flusso»?
La vista isola gli elementi, l’udito li unifica. Mentre la vista pone l’osservatore al di fuori di ciò che vede, a distanza, il suono fluisce verso l’ascoltatore. A differenza della vista, che seziona, l’udito è dunque un senso che unifica.
Walter J. Ong
Non credo che nella mia scrittura il paralinguaggio si sostituisca al linguaggio; credo, invece, che un linguaggio “puro” non esista e che tutto il linguaggio sia paralinguaggio. In fondo, siamo in grado di ascoltare musica con il corpo attraverso il livello di pressione delle onde sonore; siamo in grado di vedere un quadro attraverso il tatto che svela le tessiture materiche dei colori; e siamo in grado di godere di una poesia molto prima di comprenderla, come suggerisce T. S. Eliot in un saggio su Dante del 1929: “Genuine poetry can communicate before it is understood”. Siamo esseri plurisensoriali e la prospettiva unisensoriale tradizionale non giustifica l’esistenza di connessioni complesse tra i sensi che vanno visti, dunque, non come canali mutualmente esclusivi ma come sistemi interrelati (i sistemi percettivi di James J. Gibson). Insomma, la percezione richiede, soprattutto nell’arte, una visione radicale.
Quando comunichiamo non veicoliamo informazioni solo attraverso il senso o il non senso delle parole; comunichiamo tramite la prosodia e i tratti concomitanti la parola. Come se la parola in sé fosse un suono fondamentale e i fenomeni paralinguistici fossero i suoni armonici concomitanti (gestualità, postura, prossemica, timbro, intonazione, ritmo, durata, accento…). Per via di una formazione musicale precoce, la mia scrittura – e non solo la scrittura – ha ricevuto un imprinting acustico. Per tale motivo, è fondamentale il contatto acustico tra la madre e il piccolo. Secondo l’etnomusicologo ungherese Zoltán Kodály, l’educazione musicale dovrebbe iniziare “nove mesi prima della nascita, non del figlio, ma della madre”. Sta qui il senso di Tirrenide di una scrittura da leggersi ad alta voce.

La mia Fanciulla tartaruga (Fiorina, 2018), per esempio, è una favolesìa che pone al centro, appunto, i fenomeni paralinguistici, i tratti concomitanti o simultanei alla comunicazione verbale, che non sono verbali. Si tratta di fenomeni presenti in tutta la mia scrittura, ma nella Fanciulla sono indagati con maggiore evidenza. Il vortice anaforico dello spazio adiastematico, dove le parole non hanno un senso univoco, sembra dissolvere quel senso, ma in effetti lo potenziano in simbolo tra inconscio e ironia consapevole. I segni tentano di sfuggire al recinto della scrittura, evocati a un ritorno alla dimensione orale si lasciano sedurre da un’invincibile prosodia. Non esiste punteggiatura come se essa fosse quasi un plumbeo e prosastico intralcio al sé. D’altronde, se la punteggiatura è funzionale alla lettura silenziosa e la fanciulla tartaruga è totalmente priva di punteggiatura, è chiaro, allora, il sottotitolo del libro, viaggi ad alta voce, che suggerisce la modalità elettiva per la comprensione di tutta la mia scrittura, in realtà.
Ad alta voce, pertanto, si svilupperà l’inclinazione a un ascolto attento e non distratto come quello naturalmente indotto dalle tecnologie e dalla società di massa: intonazione, ritmo, durata e accento, in tal modo, conferiranno significato anche alla parola scritta. I tratti sovrasegmentali sono, in fondo, simili al fraseggio musicale sulla carta e agli armonici sommersi, quei suoni acuti e meno intensi di un suono fondamentale, che in musica determinano, tra l’altro, proprio il riconoscimento del timbro di uno strumento. Così come in musica esiste una acquisizione del senso tonale che consente all’ascoltatore occidentale di completare armonicamente, anticipandola, una melodia tonale sconosciuta, esiste nella lettura di un testo verbale scritto una sorta di acquisizione prosodica per via della quale un lettore è capace di trovare il significato corretto dei segni e la corretta separazione delle parti del discorso grazie all’ascolto attento nell’atto della lettura ad alta voce seppure il testo in questione sia caratterizzato dall’assenza di interpunzione. Leggere ad alta voce assimila, dunque, l’atto della lettura a quello dell’ascolto in musica. La fanciulla tartaruga si ribella alla “civilizzazione” emotiva della comunicazione di cui parla il linguista Otto Jespersen e che ha allontanato il parlato dal canto. Tutte le volte che una persona cara ci legge qualcosa ad alta voce fa sì che rileggendo da soli, un giorno, potremo riascoltare ancora quel canto, la medesima voce cara. La voce è il corpo del pensiero ed è un’esperienza intensa ascoltare i tratti sovrasegmentali e gli armonici del corpo di chi legge. Insomma, scrivere in versi significa passare da una semiosfera all’altra, dal pensiero al linguaggio e viceversa; significa stare pericolosamente fuori di quel confine semiotico, là dove la semiosi sarebbe impossibile nella teoria. Per fortuna, nella pratica, i confini dell’umano sono permeabili ed è possibile destrutturare il linguaggio verso una rinominazione delle cose che può tradursi nella nascita di un nuovo linguaggio. Se a livello idiomatico, è impossibile trasporre il mondo in una lingua altra, sul piano politico una lingua può sopravvivere solo nell’alterità della traduzione, solo nella contaminazione vitale di un’altra lingua, un altro pensiero.
Il primo testo, “dizionario verdiano”, contenuto in Tirrenide è una sorta di manifesto di poetica in una sestina. Esso è parodia in un certo senso “atonale” di un altro Dizionario, quello del musicologo Eduardo Rescigno. Se prestiamo attenzione con l’orecchio ci rendiamo conto che “muta d’accento e di pensiero” del Duca di Mantova – mi riferisco al libretto di Francesco Maria Piave, atto terzo del Rigoletto di Giuseppe Verdi – può essere interpretato sia come aggettivo sia come verbo. Come voce verbale, “muta” ricorderebbe, forse non molto verdianamente, il «mobile» del primo verso (la donna è mobile), mentre come aggettivo si addice maggiormente alla dispregiativa visione che il libertino ha del mondo femminile. In effetti, qui non ritengo fondamentale chiarire se muta sia l’uno o l’altro; mi importa, invece, focalizzare l’attenzione sulla possibilità di scavare la parola (che è polisemica per natura come lo è la poesia) e sulla possibilità della parola di contenere più chiavi di lettura. Se scavassimo nel palinsesto di ogni parola, ci accorgeremmo che esistono più significati e tutti servono a costruire la nostra realtà individuale; esiste, dunque, un’origine del linguaggio da fare riemergere e che a volte rimane oscura. L’ossimoro della “voce muta”, che sta nel contempo per voce trattenuta nel corpo – silenziosa e coincidente col corpo stesso (“voce-corpo”) – e voce che muta precipitando “di un’ottava sola”, di appena un’ottava sola e che, quindi, non muta la parola o il nome della nota musicale ma, mutando registro e senso, rovina “in un dirupo liquido”: il dirupo è la “parola” che contiene, a parte l’occlusiva bilabiale sorda, due liquide l e r. L’immagine, tenta di unificare ogni opposizione paradigmatica, solido/liquido, terra/mare, che caratterizza il poema. Il pensiero binario svanisce, in controcanto seriale, con la ripetizione finale “piano piano” che si può intendere come indicazione agogica e non solo, perché nel testo successivo si chiarisce ulteriormente che piano sta sia per livello – “al terzo piano i morti” – sia per pianoforte… La ripetizione, in questo caso, non è la ripetizione kierkegardiana che rinnova il piacere musicale attraverso la reiterazione dell’ascolto (nell’opera del filosofo, L’erotico in musica,l’opera è il Don Giovanni di Mozart) ma ripropone i significati differenti di una medesima parola. Tirrenide è un’opera anfibia dove la menzione della “voce corpo” è bilinguismo organico (“sotto una lingua a rollarne un’altra”) che scompone linguaggi eterogenei scavando nella effe del proprio esserci e nell’aspirazione alla fusione di questa anfibia “voce corpo”, delle due metà – l’una e l’altra – che aspirano all’intero.
In Tirrenide si affaccia spesso il tema del femminile e del maschile. Qual è il tuo posizionamento rispetto alle logiche non binarie del presente?
Nel migliore dei casi la società italiana, immersa in una visione tradizionale dei ruoli di genere, è imbevuta di sessismo benevolo, di convinzioni che avallano posture paternalistiche in virtù di una irragionevole superiorità dell’uomo. Purtroppo, esistono anche contesti in cui il paternalismo cede il posto a un sessismo ostile che ha come scopo quello di conservare con la violenza il potere del ruolo maschile. Forse a creare il genere è, in un certo senso, il linguaggio. Per questo motivo, soprattutto chi si occupa di scrittura dovrebbe riflettere sui modelli mentali nati da un linguaggio binario e che portano a condotte sociali “costruite” e non innate, condizionate dal potere di quel ruolo frutto di diseguaglianza.
Tutto ciò che è inclusivo, ovviamente, sottende a priori un’esclusione; dunque, tutto ciò che è inclusivo necessita di cautela e delicatezza. Probabilmente lo schwa – fenomeno linguistico e sociale? – non risolverà il problema e la sua ostentazione sui social media in alcuni casi potrà addirittura acuire i conflitti fino alla derisione aggressiva. Senza dubbio, l’indistinto, il neutro, fa paura perché è scandaglio e scandalo: “L’inconoscibile viene pensato sempre al neutro. Il pensiero del neutro è una minaccia e uno scandalo per il pensiero”, scrive Blanchot. E lo scandalo è neutralizzato spesso proprio attraverso la derisione. Ci sono dialetti dell’Italia meridionale che hanno già, in effetti, la vocale indistinta e i napoletani, per esempio, la usano per l’imprecazione mamm’t, difficile da codificare in forma scritta; oppure pensiamo alla vocale presente nei dialetti dell’Italia centrale a fine parola, per cui “bello” si pronuncia bellə. Tutto ciò, però, non è sufficiente a riplasmare l’identità del linguaggio.
Le parole rappresentano un atto di identità che definisce il sé nei confronti dell’altro: solo ciò che è nominato ha diritto di essere nel mondo. Chi scrive è l’onomaturgo che riempie il vuoto di esistenza attraverso la parola appena nata. Egli è come quel compositore dodecafonico che, nel tentativo di inventare un linguaggio musicale, utilizza i dodici suoni della scala cromatica temperata ponendoli in relazione l’uno con l’altro senza riferimento a una nota fondamentale. Una musica nuova, questa, che giungerà “stonata” nella storia della ricezione nel Novecento. Allo stesso modo, oggi, a molti parlanti suonano stonate alcune parole: avvocata, sindaca, ministra, prefetta… Abituarsi a nuovi suoni richiede tempo, ma non è solo una questione di tempo. Già la religione utilizza “avvocata” nell’antifona mariana Salve Regina, risalente all’XI secolo, nell’invocazione “avvocata nostra”; già Dante utilizza “ministra” nel verso “la ministra de l’alto Sire” (Inferno, canto XXIX). E poi, non sono più voci estranee del nostro mondo neppure spread, rating, default, che fino a cinque minuti fa rappresentavano un pianeta irraggiungibile. Giovan Battista Della Porta fornisce la prima descrizione dei “femminielli” napoletani nel De humana physiognomonia del 1586. Più di quattrocento anni dopo, nel 2008, la Commissione Europea elabora nelle ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione un documento dal titolo “La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento Europeo” dove si afferma l’impegno a utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nelle sue pubblicazioni.

Ogni cosa inizia a vivere (o a essere vista) nel momento della sua nominazione. Ciò significa che, se l’educazione musicale deve iniziare molto presto (Kodály docet), allora, per decifrare un linguaggio sconosciuto o abituarsi a uno nuovo sarà bene fornire le “istruzioni di montaggio” della novella libreria mentale ai parlanti nove mesi prima della nascita della madre, appunto. Si tratta di smantellare un pregiudizio antropico e aspirare a ulteriore specismo umano. Il non-binario non è l’umano che parla con voce animale, né l’animale che parla con voce umana; il non-binario non è un bestiario ventriloquo o una vegetazione carnivora. Nulla di tutto questo. Il grado zero, purtroppo, non è ancora vicino allo zero, neppure lontanamente. Ed è così che la mia scrittura tenta di deragliare dal binario, andare verso il neutro, dissolvere le opposizioni. E poi, la dualità è cosa terrena, è opposizione, è guerra. L’Uno è divinità – iancura e cannibalismo nella mia poetica – ma non scomoderò in questa sede la sintesi alchemica del Salvator Mundi, il Rebis, il primo Adamo, il primo capitolo della Genesi (v. 27), la Monna Lisa, Lighea, né l’Ermafrodito dormiente con due cuori nello stesso petto e neppure la sepoltura non binaria di Suuntaka Vesitorninmäki. Preferisco che tali argomenti rimangano suoni armonici, non nominati – come l’altra -esplicitamente, in quel fondale sonoro che è Tirrenide. È evidente, purtroppo, che la scienza, l’arte, l’evoluzione non hanno nulla a che fare con lo scorrere lineare del tempo: l’umanità è pronta sempre a rinnegare ogni progresso, sé stessa.
Nel testo intitolato, appunto, neutro c’è la sintesi di quanto detto. Ci sono popoli che non sono costretti nel binario del pensiero. Per quale motivo non potremmo dialogare anche noi nel segno di questa libertà? In Sicilia si è inclini quasi a credere che l’arma, l’anima, coincida con la “bocca dello stomaco” dove si manifestano le gastriti; noi isolani amiamo assegnare una funzione pratica persino a un’entità spirituale. La bocca dell’anima, quindi, inaridisce: ma solo se credi esista; se non credi, no. Suvvia, dunque, finitela, o seccherà la gola a forza di parlare. E la divina differenza scomoda Montale. Cos’altro dovrei spiegare ancora? La chiave c’è sempre nelle parole, ed è una radice ironica e amara, come la cicoria appartenente alla famiglia delle Asteraceae, “quel colore/tirrenico, quel nome di radice amara,/la grama preda dello scriba/stillante altra insonnia”, direbbe Vittorio Sereni.
Qui troverete un mio approfondimento su questo argomento.
neutro
non binaria privata e privativa
predatori della lingua il boa
la boa il genere cambia il sesso?
albero maestro la figue maestra
per fortuna isola è femmina e
il contrario non avrei sopportato
i cialtroni in subbuglio la persona
femmina in subbuglio l’umanità
femmina inutile tutto né l’una né
l’altra cose turche ma anche cinesi
giapponesi armene persiane anche
ungheresi e via via via discorrendo
e via via dicendo suvvia finitela
ti asciuga l’arma se credi esista
e se non credi no e la spiga piena
piega il capo e pure il naso pende
da un lato divina differenza dall’altro
nessuna per un osservatore raffreddato
Altre pubblicazioni dell’autrice
Alcuni testi in versi e in prosa si trovano in libri, riviste e antologie: Il rumore delle parole a cura di Giorgio Linguaglossa (Edilet, 2014); Blanc de ta nuque vol. II a cura di Stefano Guglielmin (Le voci della luna, 2016); Umana, troppo umana a cura di Fabrizio Cavallaro e Alessandro Fo (Aragno, 2016); Il Segnale. Percorsi di ricerca letteraria (I Dispari, n.103 – 2016; n.108 – 2017; n.118 e 119 – 2021); Punto. Almanacco di poesia a cura di Mauro Ferrari (puntoacapo, 2017); Trivio. Polesìa vol. IV a cura di Ferdinando Tricarico (Oèdipus, 2017); il saggio breve, “L’ondina siciliana e il sortilegio della voce” in Itinerari siciliani a cura di M. A. Ferraloro, D. Marchese, F. Toscano (Historica edizioni, 2017); Il corpo, l’eros a cura di Franca Alaimo e Antonio Melillo (Ladolfi, 2018); Fuochi complici. Saggio di critica letteraria di Marco Ercolani (Il Leggio, 2019); Sicilia. Viaggio in versi a cura di Lorenzo Spurio (Euterpe, 2019); Taccuino della poesia (Giulio Perrone Editore, 2020); Nova, rivista d’arte e scienza dal n.77 al 79, 2020 – n.80, 2021 (Il Rabdomante); Italia insulare. I Poeti a cura di Bonifacio Vincenzi (Macabor, 2021); Osiris Poetry n.84, 2017 – n. 90, 2020 – n.92, 2021 (Andrea and Robert Moorhead).