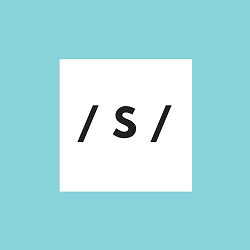Kein richtiges leben im falschen
Uno dei passaggi cardine per l’interpretazione dell’indagine butleriana relativa all’etica della cura è rappresentato dalla questione sollevata da Adorno quando, nei Minima Moralia; il filosofo afferma che non si dà vita vera nella vita falsa, “es gibt kein richtiges leben im falschen”.
Filosofi come Adorno, prima, e Butler poi nel suo saggio A chi spetta una buona vita?, individuano il declino della possibilità di perseguimento della vita buona nel contesto più ampio di un mondo strutturato dalla disuguaglianza, dallo sfruttamento, e da diverse forme di cancellazione e “rimozione”.
Di fondamentale importanza sarà allora saper cogliere la portata di tale prospettiva tale per la quale si individuano “fasci di esistenza”, vite, strutturalmente e sistematicamente deficitarie rispetto ad altre, problematiche a partire dalla modellatura che esse assumono per opera diretta del periodo storico e delle sue relative forme.
La vita buona
Ciò che è interessante delineare è la necessità di sondare il significato di una “vita buona”, di individuare, cioè, quale possa essere la migliore tra le espressioni dell’esistenza che si possa perseguire nel mondo che ci troviamo ad abitare.
Nell’analisi operata da Butler attraverso i suoi saggi si individua come problematica quella concezione di benessere legata esclusivamente alla dimensione binaria sicurezza-prosperità; il conseguimento di un benessere siffatto è perseguibile anche da chi in realtà non sta vivendo una buona vita, da chi, in sostanza, crede di viverla incentivando però logiche di sfruttamento e, più in generale, favorendo il perpetrarsi del consolidamento delle disuguaglianze. Anche la stessa espressione “la vita buona” deve essere soggetta ad una sorta di rimaneggiamento, ad un atto di critica rivolto a far emergere i limiti concettuali che tale formulazione presenta.
In accordo con il pensiero di Butler possiamo sottolineare come tale formulazione, nel contesto che vogliamo far emergere dalla critica, appartenga ad un’ottica di indubbia provenienza aristotelica legata, quindi, ad un senso di condotta che predilige forme individualistiche della sfera morale, evoluta e contaminata nel suo essere così profondamente legata alla sfera economica e non più realmente accessibile nella sua dimensione non commerciale.

Condotta etica e vita sociale
La chiave del superamento di tale concezione sarà rintracciabile solo all’interno di un ritorno ad una riflessione che indaghi quali siano gli estremi della relazione tra moralità e teoria sociale e che individui in quale modo le operazioni di potere e dominazione penetrino nelle nostre riflessioni individuali sulla forma di vita migliore.
Nel suo saggio “A chi spetta una buona vita?” è possibile vedere come Butler prenda in esame la dimensione della condotta etica in quanto mai completamente separabile dalla vita sociale e come questa sua assunzione sia corroborata dalla considerazione adorniana, presente in “Problemi di filosofia morale”, per la quale si afferma che “un individuo che esiste solo per sé stesso non è altro che una vuota astrazione.
Secondo Adorno sarebbero allora le categorie sociali a rappresentare il cuore della filosofia morale e solo attraverso questa rinnovata veste politica sarebbe possibile recuperare la forma di vita migliore: la ricerca della buona vita corrisponde, per il filosofo, alla ricerca della giusta forma della politica, ammesso che questa possa essere definitivamente raggiunta.
Proprio attraverso tali presupposti si presenterebbe la necessità di domandarsi politicamente quale “configurazione” sociale della vita aderisca maggiormente al modo in cui si possa vivere nel modo migliore. Butler implementa queste considerazioni aggiungendo che, affinché si possa rispondere soddisfacentemente a questa tipologia di domande, si deve avere una concezione della vita tale per la quale essa possa essere “condotta” e non coercitivamente guidata.
Uno spazio per le vite non degne di lutto
Nel saggio “Critica della violenza etica”, pubblicato nel 2003 e nato da un ciclo di lezioni tenute all’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte nel 2002, Butler esprime l’idea che chiedersi in quale modo poter condurre una “vita buona” determinerebbe già in noi un contrasto con meccanismi di potere governativo protesi ad un’amministrazione delle popolazioni garante di una concezione sostanzialmente differenziale, sia nello sfruttamento, sia nella precarietà costitutiva delle vite che si pongono questo atto di riflessione.
Passaggio centrale per la filosofa e per la filosofia critica sarà allora individuare queste zone grigie della socialità dalle quali emergerebbe il fatto che non si possa dare per scontato che tutti gli esseri umani viventi abbiano lo status di soggetti degni di diritti, protezione, senso di appartenenza politica e civica.
La domanda posta individualmente relativa a come conduco questa vita che è solo mia può, allora, essere legata ad una dimensione biopolitica ed essere configurata attraverso più accezioni:
quali vite sono importanti? Quali vite non sono riconoscibili come “viventi” o lo sono soltanto in modo ambiguo?
E’ proprio qui che entra in gioco, acquisendo forma e pertinenza, il quesito butleriano: quali vite sono degne di lutto e quali no? Esistono delle vite considerate non-vite o solo parzialmente viventi, già morte ancora prima di qualsiasi abbandono da parte del soggetto? Tali questioni si acutizzerebbero in prima istanza lì dove il soggetto percepisca sé stesso come dispensabile rispetto ad alcuni altri e non degno di cura; queste persone provano da subito la sensazione che la perdita della propria vita non sarà soggetta a pratiche che evidenziano un lutto, una reale mancanza. Questo significa che vite considerate non degne di lutto possono essere piante ma solo attraverso una forma di resistenza presente nella socialità, in quella penombra relegata all’”irruzione nella vita pubblica” che contesta gli schemi attraverso i quali queste stesse vite vengono valutate o svalutate.
Possiamo analizzare, in accordo con Butler, come chi vive vite svalutate, proprio per garantire altresì riconoscimento e valore alla propria esistenza, si organizzi in forme collettive tali per le quali sarebbe difficile distinguere un funerale da una manifestazione pubblica. Zone grigie e vite non degne di lutto verrebbero a conformarsi, quindi, proprio perché non vi sarebbero, nella società in cui si trovano esse stesse a vivere, strutture adeguate di supporto decretandone indirettamente l’inservibilità e incentivando la considerazione che non si debbano proteggere perché “precarie”.
 L’Io come attore sociale
L’Io come attore sociale
In quest’ottica allora solamente vite supportate, degne di lutto, potranno beneficiare di sostegno sociale ed economico, di alloggio, di cure mediche, lavoro, libertà d’espressione politica e di altre forme di riconoscimento sociale atte alla partecipazione attiva nella vita pubblica.
L’interrogativo su come poter perseguire una vita buona in una vita “cattiva” torna allora pressante e ad avere scoraggianti risvolti paradossali: la domanda implica che vi sia un io che abbia la forza di porre l’interrogativo in modo riflessivo e, quindi, che questo io possa apparire a sé stesso come possibile attore nel campo sociale di ciò che è disponibile; ma come può avere luogo questo interrogativo morale, questa sorta di richiesta di lutto pubblico, partendo da una posizione in cui ci si sente dispensabili o indegni?
Seguendo il pensiero butleriano, questa tipologia di questioni ci coinvolgerebbe positivamente in una relazione critica con gli ordini biopolitici di assegnazione valoriale delineando sin da subito la questione su come vivere una vita buona indissolubilmente legata alla pratica vivente della critica.